La Domenica di Don Galeone: “Abbiamo creduto che per essere felici occorreva solo il benessere; ora, raggiunto il benessere, siamo vittime del malessere…”
12 Dicembre 2021 - 10:00
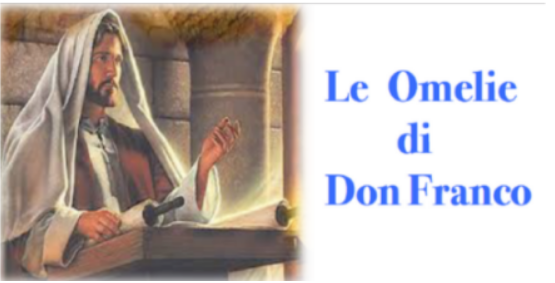
III domenica di Avvento ( C ) – 12 Dicembre 2021
Maestro, che dobbiamo fare?
Prima lettura: Il Signore si rallegrerà per te con grida di gioia (Sof 3, 14). Seconda lettura: Il Signore è vicino! (Fil 4, 4). Terza lettura: E noi che dobbiamo fare? (Lc 21, 25).
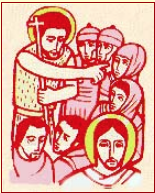
Dalla Bibbia «Guai a Gerusalemme, città ribelle! I suoi capi sono leoni ruggenti, i suoi giudici sono lupi della sera; i suoi profeti sono boriosi, uomini fraudolenti; i suoi sacerdoti profanano le cose sacre, violano la legge» (Sof 3,1-4). Così inizia il terzo capitolo del libro di Sofonia dal quale è tratta la nostra lettura. Che fare in una simile situazione? Sofonia non ha alternativa: comincia a minacciare catastrofi. Le prime parole che pronuncia, in nome del Signore, sono: «Tutto farò sparire dalla terra!» (Sof 1,2). Poi, improvvisamente, ecco la profezia contenuta nella nostra lettura. Rivolto al popolo esclama: «Gioisci, esulta, sii felice, rallegrati con tutto il cuore!» (v. 14), «non temere, non lasciarti cadere le braccia!» (v. 16). Il cambiamento di tono è tanto evidente quanto inatteso e inspiegabile. Come mai dalle minacce il profeta passa all’invito alla gioia? Cos’è cambiato in Gerusalemme? Il popolo si è forse convertito? No. La ragione è un’altra: il Signore ha revocato la condanna. Gerusalemme non verrà punita (v. 15). E’ stata una sposa infedele – è vero – ha tradito il suo Dio, ma egli non l’allontanerà da lui per sempre. La «rinnoverà con il suo amore» (v. 17).
Dal Vangelo «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all’ira imminente? La scure è già posta alla radice degli alberi; ogni albero che non porta buon frutto, sarà tagliato e buttato nel fuoco» (Lc 3,7.9). Con queste parole severe Giovanni accoglie quanti vanno da lui a farsi battezzare. Avrà anche ragione, ma di certo le sue minacce non sembrano una «buona notizia». Nella prima parte del Vangelo di oggi (w. 10-14) compaiono tre gruppi di persone – il popolo, i pubblicani, i soldati – che vanno dal Battista per avere indicazioni concrete. Si tratta di uno schema ternario di domande e risposte che serve per presentare situazioni esemplari (cf. Lc 9,57-62). E’ un artificio letterario che invita ad applicare il principio ascetico indicato dal Battista ad altri casi simili. Immaginiamo che qualcuno di noi, desideroso di prepararsi bene al Natale, rivolga questa medesima domanda a coloro che consideriamo «esperti» in campo religioso (il catechista, l’operatore pastorale, la suora, il prete). Cosa ci risponderebbero? Qualcuno suggerirebbe di recitare il rosario o altre pratiche religiose. Il Battista non sceglie questo cammino. Non suggerisce nulla di specificamente «religioso», non raccomanda pratiche devozionali, cerimonie penitenziali (imposizione di ceneri, digiuni, preghiere, ritiri spirituali nel deserto). Esige qualcosa di molto concreto: una revisione radicale della propria vita a partire dal principio etico dell’amore al fratello: ⭐︎ al popolo dice: «Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto» (w. 10-11); ⭐︎ in seguito si presentano da Giovanni i pubblicani. Sono coloro che esercitano la professione più odiata dal popolo: riscuotono le tasse e sono dei collaborazionisti dei romani; il pubblicano è il simbolo di colui che maneggia il denaro in modo «disinvolto»: Pubblicano è chi compra e vende senza scrupoli pensando solo al proprio tornaconto. A costoro il Battista non chiede di cambiare professione, ma di non approfittarsi del loro mestiere per sfruttare i più poveri; ⭐︎gli ultimi a chiedere consigli al Battista sono i soldati. Ci aspetteremmo che Giovanni consigliasse loro di gettare le armi e di rifiutare la guerra. Ma anche qui egli si mostra «tollerante». Gesù sarà più radicale e proibirà qualunque ricorso alla violenza. I soldati di quel tempo erano mal pagati e allora che facevano? Avendo le armi in mano, approfittavano della loro forza per malmenare la gente. A costoro il Battista chiede che non maltrattino nessuno e che si accontentino delle loro paghe. L’impegno morale non è un optional, ma una necessità del Vangelo. Il “fare” ha la sua importanza ma non ogni comportamento è morale. Il bene va fatto bene! Oggi tendiamo un po’ tutti ad evitare le esigenze etiche. Dimentichiamo che come non è lecito costruirci un Dio a nostra immagine, così non ci è lecito inventarci una morale a nostro uso e consumo. La morale, dico, non il moralismo! La vera morale altro non è che una risposta all’amore di Dio.
Religione? No, grazie! L’ateismo contemporaneo si presenta come una sfida inedita; la domanda non verte più su Dio ma sull’uomo, in un orizzonte ermeticamente chiuso alla trascendenza. La cultura, oggi, si presenta più come una sfida che un richiamo. La fede ha perso di ovvietà: non è più normale e pacifico credere in Dio! Nel 1300 poteva suscitare scalpore che G. Cavalcanti si accanisse a cercare “se provar si potesse che Dio non fusse”. Il suo rifiuto sembrava paradossale! Nella società attuale, l’ateo ha pieno diritto di cittadinanza, anzi, va orgoglioso della propria incredulità. La situazione si è rovesciata: non è più l’ateo che deve giustificare il proprio rifiuto, ma il credente che deve portare le prove della sua fede. L’aforisma 125 di Nietzsche contenuto in La gaia scienza “Dio è morto” sembra l’annuncio del neantropo autosufficiente. Causa di questo ateismo è anche l’incredulità dei credenti: “Auschwitz è stato opera di cristiani. Quando ebbero finito, il loro Dio era diventato un’assurdità”, ha scritto W. Hamilton, e Th. Adorno conclude: “Dopo Auschwitz, ogni teologia è ideologia e spazzatura!”. Abbiamo creduto che per essere felici occorreva solo il benessere; ora, raggiunto il benessere, siamo vittime del malessere; abbiamo creduto che i tabù sessuali fossero causa di repressione, ma dalla liberazione sessuale del complesso di Edipo e di ogni complesso, siamo approdati al libertinaggio liberticida. La maga Circe, dopo averci incantati nella sua isola Eea, ora butta giù la maschera, e ci ritroviamo sub-uomini (Odissea, X). “Dal solo uomo” siamo giunti “all’uomo solo”, disperato o eutanasiato perché senza significato.
‘Espoir’ ma anche ‘espérance’ Dobbiamo a G. Marcel una distinzione che rischiara le nostre riflessioni: l’uomo ha bisogno non solo di “espoir”, cioè speranza di avere di più, di sapere di più, di potere di più, ma anche di “espérance”, cioè speranza di essere di più, in un futuro di comunione, di civiltà dell’amore, di cultura della vita. Può Dio disattendere questo grido che sale dal fondo più profondo del nostro io? Se lo facesse, non ci troveremmo davanti al Dio biblico ma al Giove di Les mouches, di J. P. Sartre, che resta indifferente nei suoi spazi, o che talvolta getta uno sguardo su quest’aiuola che ci fa tanto feroci. Dio, invece, squarcia i cieli e scende a salvare l’uomo, ridotto a cosa impura, a panno immondo, ingiallito come foglie d’inverno! Natale è proprio questo: il passo più audace di Dio per salvare l’uomo. Dio Padre ci ama tanto da regalarci il suo unico Figlio. L’avvento è questo tempo forte e privilegiato per scoprire la profondità e l’altezza di questo paziente amore di Dio. Buona vita!

