La Domenica di Don Galeone: ” Viviamo nella società delle tecnologie dell’informazione, che ci riempiono di notizie, ma ci nascondono le verità”.
5 Settembre 2021 - 17:01
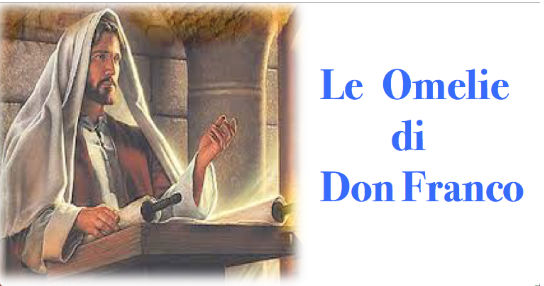
XXIII Domenica del TO (B) – 5 settembre 2021
I sordi ascoltano, i muti parlano. Ha fatto bene ogni cosa!
Prima lettura: Coraggio! Si apriranno gli occhi ai ciechi! (Is 35,4). Seconda lettura: Dio ha scelto i poveri (Gc 2,1). Terza lettura: Gesù ha fatto bene ogni cosa! (Mc 7,31).
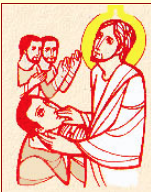
Seconda lettura (Gc 2,1-5) “Il ricco commette ingiustizia e poi alza la voce, il povero subisce l’ingiustizia e deve anche chiedere scusa” (Sir 13,3). Nella nostra società questo comportamento è accettato come normale, ma non è accettabile nella comunità cristiana. Giacomo porta un esempio provocatorio: “Ammettiamo che entri nella vostra chiesa uno con l’anello d’oro al dito … e un povero con un vestito logoro …” (vv.1-4). Dio si comporta in maniera opposta, le sue preferenze vanno agli ultimi! Nelle nostre chiese molte discriminazioni sono scomparse, ma non del tutto: ancora si riservano i posti d’onore a qualche autorità religiosa o civile o al benefattore di turno!
Dal vangelo (Mc 7,31,37) Dei quattro evangelisti, Marco è quello che racconta i fatti in maniera molto vivace e popolare; si intuisce con facilità che dietro la sua parola scritta c’è qualcuno che racconta a viva voce, attingendo al serbatoio della memoria, cioè l’apostolo Pietro. Questo spiega l’immediatezza di scene come la guarigione del sordomuto, piena di simboli e di aramaismi, come Effatà. Ma dobbiamo stare attenti, perché gli episodi evangelici, anche i più lineari, si caricano di un potenziale metaforico, che ne dilata il significato. Si rimane un po’ sorpresi di fronte ad alcuni dettagli del vangelo. Gesù non cura l’ammalato come al solito, con la semplice parola, ma lo conduce in un luogo appartato, gli mette le dita nelle orecchie, gli tocca la lingua con la saliva, alza gli occhi al cielo, emette un sospiro, pronuncia una parola aramaica, e infine gli impone il silenzio. Premesso che Gesù si adegua alla mentalità del suo tempo, osserviamo: > il malato non è un sordomuto ma un sordo che parla a fatica; questo significa il termine greco molto raro μογιλάλον; potremmo tradurlo oggi con sordo balbuziente; > al tempo di Gesù (e ancora oggi per molti!) tutte le malattie erano considerate un castigo di Dio ma la sordità era addirittura una maledizione perché impediva di ascoltare la parola di Dio; > il sordomuto non si presenta da solo ma viene accompagnato da alcune persone; con questo, l’evangelista Marco ci vuole dire che per arrivare a Cristo è necessario che qualcuno ci aiuti; > il miracolo avviene lontano dalla folla e alla fine Gesù ordina di non raccontare nulla a nessuno. Gesù aveva ancora in mente quanto abbiamo sentito qualche domenica fa: l’equivoco della folla che davanti alla distribuzione del pane lo voleva fare re! > il gesto della saliva sulla lingua del muto va spiegato nella concezione popolare del tempo: la saliva era considerata un concentrato dell’alito, una materializzazione del respiro. Gesù ha voluto comunicare il suo spirito; > Effatà (Εφφαθά) è una parola aramaica, la lingua parlata da Gesù, e significa Apriti! Non è rivolta all’orecchio ma all’uomo: è l’invito a spalancare le porte del cuore e lasciar entrare Cristo. Quell’imperativo Effatà, perciò, è rivolto a ciascuno di noi.
L’arte di dialogare per comunicare Se è vero che “fides ex auditu”, allora come è ancora possibile annunciare il vangelo oggi? Noi ci siamo costruiti una specie di periostio difensivo; la nostra sordità è garanzia di sopravvivenza! Ma è inutile nascondere il problema. Ripenso a quel grande testimone di don Lorenzo Milani, che ha dato la parola ai muti e l’udito ai sordi. Però, per fare questo, ha dovuto ricordare alle professoresse e ai professori che loro erano i sordi e i muti. Se ci riconosciamo bisognosi di dialogare, allora impariamo l’alfabeto della comunicazione. Ma non è facile, perché noi ci aggrappiamo al linguaggio della nostra consorteria, che ci rende graditi e omogenei. Gesù, che liberava i sordi e i muti, in senso fisico e in senso morale, era considerato un pazzo; egli non andava verso gli ultimi per conto del sistema, come può andare un maestro inviato dal ministero a fare la sua lezione, secondo i programmi stabiliti dall’alto. Gesù era inviato solo dal Padre, come dire, da nessuno; perciò diceva cose che turbavano profondamente i detentori del potere civile e religioso; per questo fu deriso prima della crocifissione, e ancora oggi le sue parole passano per folli in certi ambienti. Se già era difficile la comunicazione umana al tempo di Gesù, più difficile lo è in questi tempi, nei quali abbiamo la tecnologia della comunicazione più sviluppata. E tuttavia ogni giorno ci comprendiamo di meno e comunichiamo di meno. Perché? Perché abbiamo in abbondanza “informazione” e ci manca “comunicazione”. L’attualità di questo vangelo è avvincente. Viviamo nella società delle tecnologie dell’informazione, che ci riempiono di notizie, ma ci nascondono le verità. E soprattutto ci allontanano dalle persone, dai loro problemi, dal dolore e dalla gioia che vivono gli esseri umani. Sappiamo molto degli altri, ma non li conosciamo, i loro veri problemi non ci interessano. E così capita che ogni giorno siamo più soli. E finiamo con l’essere più egoisti. Oggi abbiamo un’eccellente “teoria dell’azione comunicativa” (J. Habermas). Ma di fatto l’informazione (manipolata) sta rendendo ogni giorno più complicata la vera comunicazione che ci rende più trasparenti verso le persone.
Effatà … Apriti! La parola aramaica Effatà è centrale nel racconto evangelico del sordomuto. E’ un imperativo, e indica l’efficacia della parola di Gesù, simile a quella di Dio creatore. Gesù fa sul malato delle azioni a prima vista magiche: mette le sue dita sulle orecchie sorde, tocca con la sua saliva la lingua muta, emette un sospiro guardando il cielo; si tratta di gesti terapeutici arcaici, testimoniati sia nel mondo romano che in quello giudaico. Ma ecco quell’imperativo di Gesù: “Apriti!”, che segna l’irruzione di Dio nella vita. Il nostro errore è quello di pensare che i protagonisti siamo noi, sia nell’ascolto che nella parola. Questo vangelo ci ricorda che Uno solo è capace di guarirci dal nostro mutismo e dalla nostra sordità. Senza l’incontro con Gesù, nonostante le apparenze di loquacità e di auditività, noi tutti siamo dei poveri sordomuti. Molte volte la Bibbia descrive la situazione del popolo ebraico come sordo e muto all’ascolto di Dio; naturalmente l’iniziazione alla fede viene descritta come una guarigione dalla nostra sordità e dal nostro mutismo. Perciò il rito del battesimo si conclude con questo augurio: “Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di udire presto la sua parola”.
Né spiritualismo né temporalismo! Gesù non ha detto “occupatevi dell’anima” ma “guarite i malati”; gli spiritualisti parlano di trascendenza, perché trovano comodo trascendere, scavalcare, la realtà scomoda della sofferenza. La Madonna, invece, esalta un Dio che “ha rovesciato i potenti dai troni”. E’ ipocrisia consolare chi vive nella miseria, facendogli credere che è “ricco di fede”. E’ vero che il messaggio cristiano non si esaurisce in un progetto di riscatto sociale, ma questo non significa che il vangelo non tocchi anche il corpo, la materia, la storia, l’economia, la fame, il dolore. E’ un errore “fermarsi lì”, al temporale, ma è anche un errore non promuovere cammini di liberazione; è vero che la chiesa è portatrice di “qualcos’altro”, ma è anche sbagliato parlare sempre … di “altro”. Anche in questo, Gesù è un maestro di equilibrio: alle folle affamate ha prima dato il pane della terra, e poi ha fatto il discorso del pane del cielo!
In quel tempo Gesù raccontò questa parabola: Alla sinagoga bussò un giovane sporco e malridotto. Era uno spacciatore, ricercato dalle guardie e non sapeva più dove nascondersi. L’anziano rabbino aprì la porta, ma fu imbarazzato da quella visita. «Mi faccia entrare. Sono disperato!». «Va bene. Questa notte puoi rimanere qui. Ma solo per questa notte. Domani mattina te ne devi andare!». Quella notte l’anziano rabbino morì e arrivò in cielo. Dio lo accolse con gentilezza e gli disse: «Vieni! Questa notte puoi rimanere qui. Ma solo per questa notte. Domani mattina te ne devi andare!» (dai racconti di Bruno Ferrero).


